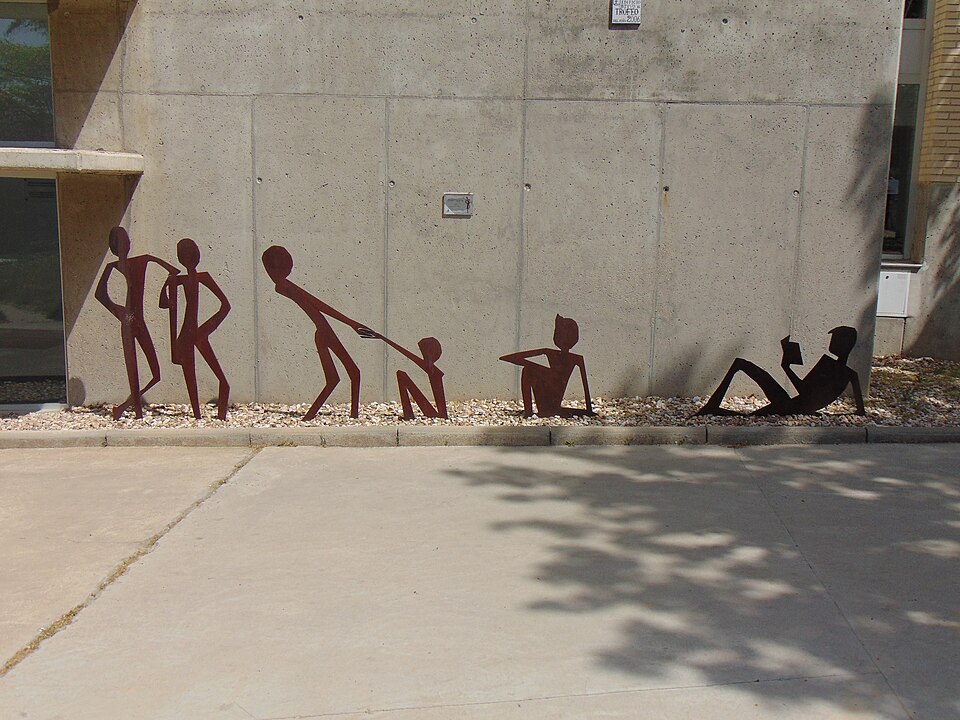Contributo a cura di Carola Carazzone, segretario generale Assifero e vicepresidente di Philea
Oggi viviamo uno di quei momenti storici in cui abbiamo l’opportunità di cambiamenti trasformativi. In una situazione di trasformazione epocale come quella in cui viviamo diventa fondamentale porsi alcune domande scomode sulle nostre organizzazioni e sui noi stessi. Chi siamo? Perché facciamo quello che facciamo? Quale è la differenza che vogliamo e possiamo fare per noi stessi, per le persone che amiamo, per la comunità in cui viviamo, per l’umanità, per il pianeta?
Anche per quanto riguarda le fondazioni ed enti filantropici italiani queste domande possono contribuire a tracciare la rotta che vogliamo intraprendere. La questione preliminare riguarda la propria identità di ente filantropico: che ruolo si vuole avere nella e per la società? Generalizzando e semplificando, si mira a mantenere lo status quo o si vuole promuovere cambiamento sociale, spostare potere, partecipazione, agency?
Alleviare sofferenza, tamponare emergenze, restaurare un po’ di bellezza oppure contribuire ad eliminare le diseguaglianze, promuovere cambiamento sociale, lavorare per un cambiamento sistemico, sono mestieri molto diversi.
Spesso in Italia, in una visione limitata e limitante che confonde il fine con uno degli strumenti, le fondazioni sono state definite e percepite come enti di erogazione.
A partire dal vissuto collettivo degli anni del Covid, molteplici fondazioni ed enti filantropici internazionali hanno messo in discussione le modalità tradizionali di finanziamento, che hanno caratterizzato gli ultimi 35 anni basate su logiche erogatrici vincolate a progetti di breve periodo e a un controllo rendicontativo su attività e KPI per adottare approcci più generativi centrati sulle organizzazioni e sui processi di cambiamento sistemico.
Gli enti filantropici, rispetto agli enti pubblici e ad altri tipi di finanziatori, sono quelli che in teoria detengono la più ampia libertà di decisione e azione, flessibilità e agilità eppure per decenni hanno introiettato una sorta di isomorfismo rispetto ai donatori pubblici (in primis l’Unione Europea) e ministeriali: bandi – progetti – rendicontazione.
Per quanto riguarda poi gli enti del terzo settore per propria natura generativi come le imprese sociali e le imprese creative e culturali, in Europa solo l’1% del capitale di cui le imprese sociali hanno bisogno proviene dagli enti filantropici, nonostante questi ultimi dispongano teoricamente del tipo di capitale che potrebbe fare la differenza: paziente, flessibile e solidale. Gli enti filantropici si collocano all’ultimo posto tra gli impact capital providers, dopo istituzioni finanziarie (64%), investitori individuali (27%) e fondi pubblici (5%).
L’attuale sistema di finanziamento basato su cicli di progetti si rivela inadeguato di fronte alla velocità dei cambiamenti, alla complessità delle sfide intersettoriali e ai tempi necessari per il cambiamento sistemico. Questo approccio crea un’illusione di linearità e determinismo che porta a misurare le cose sbagliate: output e KPI anziché impatto reale.
Il modello a progetti produce effetti devastanti sulle organizzazioni: più del 50% degli enti non profit sopravviverebbe solo 21 giorni senza progetti, confermando l’enorme sottoinvestimento cronico nelle organizzazioni. Questo ciclo di fame perpetuo rende le organizzazioni meno attrattive per i talenti, impedisce la coesione dei team e ostacola l’apprendimento organizzativo.
Verso modalità generative: processi abilitanti del cambiamento e investimento sulle organizzazioni
Le imprese sociali che ambiscono al cambiamento sistemico hanno bisogno di un approccio radicalmente diverso: le organizzazioni a scopo sociale che vogliono produrre un impatto sistemico hanno infatti bisogno di capitale paziente e flessibile a sostegno di processi e non di progetti.
Gli enti filantropici possiedono caratteristiche uniche che li rendono ideali per questo nuovo approccio : la disponibilità di diversi tipi di risorse (continuum of capital), l’autonomia e la flessibilità nella gestione delle risorse e la proiezione di lungo periodo (20-30 anni o più).
Alcune sperimentazioni pionieristiche stanno già aprendo la strada a una trasformazione innovativa delle modalità di finanziamento nel panorama italiano: Restart Italia che utilizza lo strumento del “recoverable grant” grazie al quale in caso di successo le risorse a fondo perduto vengono restituite a un fondo rotativo per altre imprese e Fondazione MeSSinA che sviluppa il concetto di “capability capital” per intervenire a supporto dello stato patrimoniale delle famiglie.
A favorire questo tipo di approcci, è intervenuta la Risoluzione n. 75 del 21.12.2023 dell’Agenzia delle Entrate che ha confermato la possibilità per gli enti filantropici di fare investimenti, purché senza ritorno finanziario, aprendo alla scalabilità dell’uso di capitali pazienti e solidali per l’economia sociale.
E’ evidente però che il passaggio richiesto a forme di filantropia generativa non è solo tecnico ma culturale, in quanto comporta un cambio di visione, di mentalità e di paradigma culturale che ha profonde conseguenze non solo sulla durata e modalità dei finanziamenti, ma anche sul portfolio di strumenti di intervento e sulla natura delle competenze occorrenti agli enti filantropici.
Le imprese sociali trasformative richiedono infatti metriche e logiche di performance diverse dalle aziende profit: accountability verso i beneficiari anziché gli azionisti, collaborazione come mindset fondativo, orizzonte temporale di lungo periodo, scaling deep e out anziché solo up, focus sull’impatto indiretto e collettivo.
Approfondiremo questi temi durante l’incontro Per una nuova filantropia.
La partecipazione a tutti gli eventi è gratuita su iscrizione.